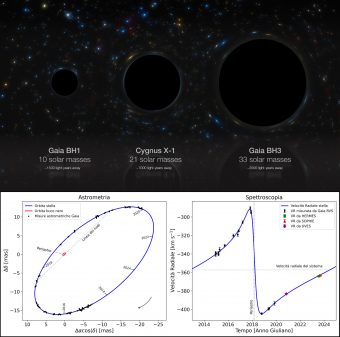Siguiendo el pensamiento de Raymond Aron, tomado de Clausewitz, que dice “la guerra es un camaleón”, afirmamos que la misma se encuentra en constante evolución y modificación. Mutando su naturaleza, contenidos, procedimientos y alcance. Y cuando creemos que se ha agotado en sus manifestaciones, se revela con mayor fuerza en otros aspectos, muchos más agresivos, morbosos e imprevistos.
La pregunta estratégica por definición no es aquella que se refiere al “qué hacer”, sino la que pregunta “de qué se trata”, cual es el eje del problema, lo medular, lo sustancial, lo conceptual. Si no se tiene el concepto de lo que ocurre, no se puede operar sobre la realidad. La misma se torna caótica, ingobernable.
Lo que es verdaderamente relevante, desde el punto de vista estratégico, es lo nuevo, no lo que se repite. El cambio y el conflicto derivado, no la continuidad y la estabilidad. La novedad, en el caso de la Guerra Fría, fue la ausencia de la derrota militar clásica, en batalla. Hubo un colapso estratégico, no militar, en el ámbito de esta confrontación mundial nuclear.
En efecto, durante el primer decenio la “posguerra fría” (1991/2001) se registraron 108 conflictos armados, en 73 lugares diferentes del planeta, cubriendo todas las gradaciones de intensidad:
- menores, en los cuales el número de bajas registradas durante su transcurso es superior a 25, pero menor a 1000;
- intermedios, con más de 1000 bajas durante su transcurso pero, en cualquiera de los años considerados, menos de esa cantidad y más de 25; y
- mayores (o literalmente guerras “de la primera especie”), con más de 1000 bajas fatales en cualquiera de sus años de desarrollo.
De los mencionados 108 conflictos, 92 de ellos fueron intraestatales, sin intervención de terceras partes externas; otros 9 fueron intraestatales, aunque con algún tipo de participación extranjera; finalmente, los 7 restantes fueron interestatales.
La guerra fría se caracterizó por la determinación y la identificación concreta de los adversarios en disputa. A través de la disuasión nuclear, se materializó la “pax nuclear”, los únicos 40 años de paz consecutivos en Europa, desde hace cinco siglos. La crisis actual es la repentina irrupción de lo novedoso, que cambia los datos del problema y provoca como efecto la obsolescencia de las categorías conocidas para resolver el conflicto. Estos, en vez de constituir hechos excepcionales, tienden a transformarse en acontecimientos permanentes.
El cambio tecnológico es la fuerza que impulsa el proceso de globalización de la economía mundial y en particular del sistema financiero, mientras desde el punto de vista político las culturas intentan su reafirmación, dentro de la integración o continentalismo.
Una de las características de la revolución tecnológica es el procesamiento de una masa de información que permite tomar decisiones estratégicas en tiempo real y a escala planetaria. Ello ha cambiado el ritmo de los acontecimientos en las culturas desarrolladas. Contrariamente, en las culturas subdesarrolladas han irrumpido las crisis generalizadas, abarcando a todos los sistemas institucionales: políticos, económicos o sociales.
Surge la percepción de una extraordinaria incertidumbre en regiones deprimidas, ante los cambios cualitativos que no pueden ser incorporados. Las categorías del pensamiento, propio de épocas pasadas, no están en condiciones de abarcar y conceptualizar lo que está pasando hoy. La clave del presente, ante lo expuesto es: limitar la incertidumbre, reconociendo el carácter inexorable del avance tecnológico, y al mismo tiempo estar en condiciones de dar una respuesta, siempre tentativa, a la pregunta crucial: ¿Qué tenemos frente a nuestros ojos?, ¿Porqué ocurre?; y transformar esa incertidumbre en riesgo, a través del planeamiento. Acotar la irrupción de lo nuevo, sus condiciones y características: sus esencias. La tarea clave es ver lo que los ojos no ven, evitar bucear en la dualidad. Abarcar y focalizar lo nuevo, para concentrar las energías.
Ante una situación de irrupción de lo nuevo, la tarea fundamental está en el campo de la Inteligencia Estratégica. Pero por encima de la Inteligencia Estratégica está la Sabiduría Política, que consiste en dirigir los esfuerzos institucionales según la naturaleza del conflicto que tenemos por delante.
Ante un conflicto nuevo, que emerge, la responsabilidad de la seguridad estratégica del Estado, consiste en nunca dar por seguro lo peor, como decía Churchill. Pero, como complemento de esta afirmación, la responsabilidad político-estratégica–militar, consiste siempre en prever la peor hipótesis. Decía De Gaulle: “el Ejército es una Institución que de nada sirve, salvo cuando todo depende de ella”.
La confluencia entre el pensamiento estratégico y el político-diplomático, que nunca da por seguro lo peor, debe enfrentar hoy a los novísimos conflictos post-Guerra Fría. En éste mundo en constante cambio, de acelerado ritmo, las crisis constantes así lo exigen.
Hoy toda organización política estatal que no sea estructuralmente flexible y capaz de adaptarse dinámicamente al medio, a través del acceso directo e instantáneo a la información procesada, de alcance mundial, estará buscando inconscientemente su propia inmolación.
En nuestra opinión la versión contemporánea de la guerra civil está asociada a la ruptura del Estado. Podríamos conceptualizarla de la siguiente forma: “Una parte de la comunidad rechaza los procedimientos establecidos para la resolución de conflictos y opta por recurrir a la fuerza armada para imponer sus criterios sobre la organización política, económica o territorial de la colectividad. Si la violencia entre los dos bandos se extiende en términos temporales y alcanza un cierto umbral de intensidad medido en perdidas humanas y materiales, se puede hablar de guerra civil. Durante el enfrentamiento, los rebeldes construyen un aparato paraestatal alternativo que oponen a la administración oficial. Durante un cierto tiempo, dos o más autoridades se enfrentan hasta que una destruye a la otra y monopoliza el control sobre población y territorio. Bajo esta definición se pueden englobar muchos de los enfrentamientos domésticos en el área Sur durante la última Guerra Mundial, comúnmente llamada “Guerra Fría”.[1]
La guerra, como cualquier otro fenómeno de la civilización en curso, está sometido a los cambios y vaivenes que experimenta la propia sociedad, ya sea por razones políticas, económicas, tecnológicas o de cualquier otra índole. La evolución de la guerra se ha caracterizado por una amplitud progresiva en todas sus magnitudes. La guerra hasta la revolución francesa llevaba una vida separada del conjunto de la sociedad. Según Leo Hamon[2], la guerra moderna se ha transformado en un fenómeno de masas, donde retaguardia y vanguardia tienden a confundirse. Donde las pérdidas en vidas humanas no discriminan entre combatientes y no combatientes. Y donde el respaldo técnico, industrial y económico, son aspectos claves en el desarrollo de este fenómeno. Por eso la guerra moderna, afirma el citado autor: “Exige una movilización psicológica que persuada a la Nación entera de la necesidad vital de aceptar estos sacrificios para evitar males mayores. Nadie ha de ignorar que concierne a todos”.
El carácter de los enfrentamientos civiles se puede entender con más precisión si se aplica el concepto de “guerras de tercera clase”, tal como lo desarrolla Kart Holsti[3]. Para dicho autor, este tipo de conflictos son una forma distinta de guerra, que se desarrolla en el interior de los Estados en lugar de hacerlo en la esfera internacional: “Los asuntos en juego no son intereses de política exterior, sino pugnas de raíz ideológica o problemas sobre la definición de la comunidad política que pueden conducir a UNA SECESIÓN O UNA UNIFICACION. En este contexto, las hostilidades tienden a prolongarse sin un acto formal que marque su inicio (declaración de guerra) ni su final (armisticio). No existen frentes, ni uniformes, ni respeto a los límites territoriales y la división entre combatientes y civiles se diluye, convirtiendo a todos por igual en objetivos. Estos rasgos hacen distintas a las “guerras de tercera clase”. No son conflictos sobre intereses, sino sobre hombres, en tanto que unidades básicas de la sociedad política.”
La historia demuestra que los grandes cambios sociales han influido decisivamente en la forma de relación social a través del enfrentamiento violento, conocido como guerra. La transición en curso desde la sociedad de la Revolución Industrial a la que resulta de la Revolución de la Información, nos anuncia otro cambio en los modos de hacer la guerra, cuyo alcance trataremos de definir.
Algunos autores como Lind, Schmitt y Wilson[4], brindaron una visión prospectiva de cómo podrá evolucionar el arte bélico hacia un estado que denominan la “Cuarta Generación de la Guerra”. Identifican las tres generaciones anteriores como aquellasbasadas, respectivamente, en el empleo masivo de hombres, del fuego y de la maniobra. En la actualidad se estaría entrando en la “cuarta generación” que, a pesar de los enormes adelantos tecnológicos, se basaría fundamentalmente en la fuerza de las ideas.
Se concretaría en un complejo enfrentamiento que abarcaría todos los aspectos de la actividad humana: cultural, social, política, económica y militar, empleando profusamente los medios de comunicación social y las redes informáticas para difundir mensajes.
A principios de los ’90, Martín Van Cleveld, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su obra “La Transformación de la Guerra”[5] anunciaba importantes cambios en los motivos por los que se hace la guerra, los actores que participan en ella, las finalidades que persigue y los modos que emplea. Su análisis parte de una premisa básica: “El paradigma que ha presidido la guerra moderna, en la que los Estados se ven abocados al conflicto bélico por razones de estado, empleando organizaciones militares permanentes para enfrentarse a otras parecidas, donde sus actores adquieren el carácter de combatientes, con las poblaciones apoyándolas pero separadas de ellos, en definitiva, lo que se conoce como la “trinidad clausewitziana” de pueblo, ejército y gobierno, ha sido históricamente, una excepción.”
A lo largo de los tiempos, la guerra ha sido practicada por familias, clanes, tribus, ciudades, órdenes religiosas e incluso por empresas, como la Compañía de Indias Orientales británica. Los motivos por los que se iba a la guerra también han sido diversos: tierras de cultivo, mujeres, botín, esclavos, pureza de la raza. Normalmente se ha empleando a la población, en forma de milicia, como instrumento para hacer la guerra. La razón de estado como causa de guerra y las grandes burocracias militares como medio para llevarla a cabo son rasgos de la modernidad, que se han desarrollado paralelamente con el auge del Estado-Nación moderno.
La conversión de los individuos a una determinada creencia o conciencia, ha sido uno de los objetivos clave de la guerra. Paralelamente, rasgos étnicos, culturales, sociales o ideológicos identifican a miembros de otra comunidad como adversarios, al margen de que empuñen o no un arma. La consecuencia inevitable es que, en estos casos, guerra y política dejan de ser la continuación una de la otra, para fusionarse en una única actividad.
El papel clave del Estado, como única fuente legitima de empleo de la fuerza, se fragmenta en esos casos en una serie de grupos facciosos que se arrogan ese derecho, sobre un palmo de territorio y población. Desde luego, es propio de los conflictos domésticos un cierto grado de caos y los combatientes de las “guerras de tercera clase” no son ejércitos bien organizados, atados al derecho de la guerra, sino bandas o grupos irregulares coordinados de una forma más o menos vaga, operando fuera de toda “convención”.
Sin embargo las nuevas guerras internas, en la posguerra fría, van más allá: desarrollan enfrentamientos entre un número indefinido de núcleos de poder independientes que actuando en red y con agenda propia de intereses, poseen recursos militares y económicos suficientes para impulsar desafíos hasta hoy desconocidos. La multiplicación de las bandas criminales organizadas provoca una multiplicidad de delitos que agravian la supervivencia del Estado, impulsan al delito común e inducen a los ciudadanos a asumir la responsabilidad por su propia seguridad y perseguir sus objetivos por el único medio posible, en ese clima social, el uso de las armas.
Es este escenario, de generalización conflictiva, lo que se puede definirse como “expansión y descentralización de la violencia”. Un proceso cuya fase final parece conducir a un retorno al estado de naturaleza, en el sentido “hobbesiano” del término. La descentralización y expansión de la violencia implica necesariamente una fusión de la violencia política y el delito común.
Una serie de factores contribuyen a este proceso. Para empezar, la debilidad institucional del aparato estatal y el consecuente caos, propio de los conflictos civiles, crea las condiciones para una creciente impunidad, que retroalimenta su explosiva expansión. Pero además, la separación entre organizaciones criminales y organizaciones políticas violentas, tiende a difuminarse. Delincuentes e insurgentes se distinguen por sus fines. Los primeros buscando el beneficio económico y los segundos centrados en sus objetivos políticos. Sin embargo, esta separación ideal tiende a borrarse. Para empezar, terroristas y guerrilleros politizados se involucran en actividades criminales para financiarse. El caso de la guerrilla colombiana y el tráfico de narcóticos resultan muy ilustrativos. Es muy común la práctica de otras acciones delictivas, como el secuestro y la extorsión, hasta el punto de que muchas veces resulta difícil identificar cuando una acción ha sido cometida por una organización de raíz política o puramente criminal.
Además, es posible encontrar a grupos del crimen organizado que tienden a politizarse en la medida en que sus intereses crecen, hasta convertirse en un problema de Estado. La infiltración del Crimen Organizado Transnacional en las estructuras políticas latinoamericanas, en la actualidad, es un ejemplo acabado de esta afirmación.
Un factor que ayuda a explicar la proliferación de los procesos de descentralización de la violencia en el contexto de la Posguerra Fría es la creciente debilidad de los aparatos estatales, particularmente en los países del antiguo bloque soviético y del mundo subdesarrollado. En el caso de los antiguos Estados socialistas, la ineficacia y corrupción de la antigua burocracia totalitaria, el hundimiento de la economía centralizada y la crisis de legitimidad del poder político, unidos al surgimiento de nacionalismos disgregadores, han hundido al Estado en una crisis de supervivencia.
En lo que a Latinoamérica respecta, desde el comienzo de la Guerra Fría en 1947, conjuntamente con algunas regiones de África y del sudeste asiático, ha sido el espacio de confrontación indirecta de ambos bloques imperiales, con consecuencias catastróficas para la Región. La violencia revolucionaria se montó sobre la hereditaria debilidad de los Estados regionales y sobre los odios sociales. Su resultado fue la malversación de las Instituciones, el consiguiente debilitamiento de las estructuras de poder, la transculturación y su consecuente “discordia social”. El caldo de cultivo ideal para transformarse en asiento natural del Crimen Organizado Transnacional y el germen propicio para las guerras civiles fraticidas.
Un segundo aspecto, estrechamente asociado a la debilidad del Estado, ha sido la reaparición de fuertes solidaridades subnacionales o transnacionales. Estos lazos no son nuevos pero han permanecido ocultos durante décadas bajo el peso de estructuras burocráticas más o menos artificiales. Sin embargo, el debilitamiento de los aparatos gubernamentales y su creciente crisis de legitimidad, han hecho emerger al clan, la tribu, la etnia o la religión, como principales ejes de movilización política, capaces de fracturar a los Estados. Al mismo tiempo el Crimen Organizado Transnacional, cuyos componentes centrales en la Región son el narcotráfico y el terrorismo, le otorgan a dichas estructuras la capacidad financiera y los aparatos de violencia sin los cuales la viabilidad de esas estructuras sería nula. Son dos andamiajes de distinto origen, pero que se alimentan mutuamente.
La difusión de las innovaciones tecnológicas ha tendido a potenciar las capacidades de actores independientes, de pequeño tamaño. Un buen ejemplo de esta tendencia puede verse en el impacto de los cambios tecnológicos en el tráfico de narcóticos. A principios de los años 70, el contrabando de cocaína se realizaba al por menor, con correos (“mulas”) que llevaban consigo pequeñas cantidades de droga. Una década más tarde, la introducción de avionetas permitió transportar cargamentos mucho mayores, de forma más rápida y difícil de controlar. A medida que se introdujeron aviones de mayor tamaño y sistemas más sofisticados de comunicaciones y ocultamiento, la cantidad de estupefacientes y los beneficios obtenidos se multiplicaron. Paralelamente, la informatización y globalización del sistema financiero internacional facilitaron los canales para blanquear una cantidad creciente de dinero sucio. Como consecuencia, grupos relativamente pequeños han tendido a incrementar su importancia dentro del negocio de los narcóticos. El desarrollo del armamento portátil, los explosivos y los sistemas de detección y comunicaciones han multiplicado el poder de destrucción de organizaciones pequeñas de la delincuencia común como del terrorismo político. La capacidad militar del combatiente individual nunca ha sido tan elevada como en la actualidad.
Según dos prestigiosos autores norteamericanos, Robin Wright y Doyle MacManus[6], las guerras del futuro presentarán los siguientes cambios cualitativos:
- Los factores que contribuirán a los conflictos serán más variados en origen, tácticas y objetivos, por lo tanto tendrán efectos desestabilizadores sobre todo el mundo en su conjunto.
- La adquisición de armas por parte de países del Tercer Mundo, especialmente las de destrucción masiva, harán más probable la guerra y, además, una vez iniciado los enfrentamientos se requerirá la acumulación de importantes recursos materiales y humanos.
- Mientras en los países desarrollados se está teniendo éxito en llegar a acuerdos de control de armamentos, nuclear y convencional, estos intentos están fracasando en los países en vías de desarrollo, que sumado a la disminución de la capacidad de influencia política de las grandes potencias en estos países, lleva a pensar que los conflictos serán más probables en el siglo XXI.
- Las guerras en las décadas futuras serán mayoritariamente conflictos de “baja intensidad” entre milicias y bandas equipadas con armas convencionales, cada vez más circunscriptas al interior de los Estados y las causas fundamentales serán pugnas por alcanzar el poder, la redefinición del Estado-Nación y rivalidades étnicas o religiosas.
- Predominará lo que otros autores llaman el “efecto libanización”, es decir, la disgregación de los Estados.
- La falta de armonía social en la nueva Era, provocará el aumento del terrorismo. Éste obtiene la mayor parte de los objetivos que se propone conseguir, dada la iniciativa estratégica que asume, frente a la lentitud de los perimidos sistemas de Defensa actuales.
Para Alvin y Heidi Toffler[7], los cambios revolucionarios que se han producido en el mundo y que han dado origen a “una tercera ola”, van a modelar la nueva guerra de acuerdo a esa civilización y, por lo tanto, no podemos pretender sostener ese conflicto con procedimientos de la “segunda ola”. Es necesario adoptar acciones revolucionarias en búsqueda de la paz. Para ello, hay que comprender que las transformaciones que experimentan el poder militar y la tecnología bélica, corren de manera paralela a las transformaciones económicas y sociales. Para evitar el conflicto, será necesario adoptar una estrategia actualizada de “antiguerra”, es decir, un cúmulo de acciones que garanticen la vida en paz.
Según estos autores el verdadero esfuerzo se sitúa en la correcta conceptualización de la guerra y de la “antiguerra”. Los conceptos que tenemos hoy en día están totalmente obsoletos y anticuados. Hemos analizado los conflictos pasados y pretendemos proyectar sus soluciones a las que tendremos en el futuro. Según Toffler, con la Tercera Ola alcanzan límites extremos tres parámetros distintos de la evolución del poder militar:
- El alcance.
- La velocidad.
- La letalidad.
Se producen así profundas transformaciones en la naturaleza y formas de la guerra y la prevención de los conflictos. Estas requieren significativos cambios cualitativos en el campo de la estrategia, de la táctica, de las organizaciones, las doctrinas y el adiestramiento.
Una cuarta dimensión que puede agregarse a esta matriz es el concepto actual de “tiempo”.
Una de las principales debilidades de nuestro Sistema de Defensa y de Inteligencia derivado, consiste en que durante largos períodos se desarrollaron capacidades, identificación de amenazas y previsión de operaciones, sin considerar el tiempo real como factor decisivo. Mantener dicha categoría de pensamiento en la actualidad, es suicida. Hoy el enemigo puede ser anónimo, puede emplear capacidades no convencionales, tales como ataques electromagnéticos o electrónicos contra comunicaciones esenciales y nodos informáticos y puede hacerlo de la noche a la mañana, sin advertencia previa.
Para las comunidades de Defensa y de Inteligencia Estratégica, el mayor desafío del siglo XXI es el factor “Tiempo Real”. Al tratar con la crisis y el “caos”, como el que a diario nos toca vivir, en medio de la incertidumbre, sin Planeamiento Estratégico, sin conceptualización y sin acotamiento de riesgos, los conflictos sangrientos surgen “espontáneamente” y siempre de manera “imprevista”.
La habilidad para crear en la contingencia, “justo a tiempo”; para responder de manera decisiva, “justo a tiempo”; va a ser el único camino crítico de una Política de Defensa y de una Inteligencia Estratégica exitosa en el siglo XXI.
Las guerras del siglo XXI reflejan y reflejarán, como no puede ser de otra manera, la etapa de la civilización que transitamos. El método de crear riqueza de esa civilización se caracteriza por los siguientes factores:
- El conocimiento como factor esencial en la producción.
- La desmasificación de la producción en serie.
- La necesidad de mayor calificación para acceder a los puestos de trabajo, lo que imposibilita el intercambio laboral.
- La continua innovación para poder competir.
- El tamaño reducido y diferenciado de los equipos laborales.
- La desaparición de la uniformidad burocrática.
- La aparición de nuevas formas de dirección y de “integración sistémica”.
- La integración mediante redes electrónicas.
- La gran velocidad y aceleración de todo tipo de transacciones.
Todos estos parámetros, exponentes de la forma de hacer riqueza en la era de la información y el conocimiento, son también propios de la forma de desarrollar su modo de guerrear específico, que va a tener sus propias características diferenciadoras con la actividad bélica de épocas precedentes. En las guerras actuales se presentan conceptos bélicos que combinan los modos y formas desarrollados por civilizaciones anteriores.
Entre las características que definen a las guerras de la “civilización del conocimiento”, podemos citar:
- El frente no define el lugar donde se desarrolla el combate principal, porque éste se ha extendido, se ha expandido en todas sus dimensiones: naturaleza, distancia, altura y tiempo. Se encuentra tanto en la vanguardia como en la retaguardia y ésta es mucho mas profunda. En ésta se incluyen los centros de mando, control y comunicaciones del enemigo, su cadena de apoyo logístico y su sistema de defensa aérea.
- El conocimiento es el recurso crucial de la capacidad de destrucción.
- La iniciativa, la información, la preparación y la motivación en los soldados es más importante que su puro número.
- Los daños serán selectivos, disminuyendo los colaterales.
- Las armas inteligentes van a requerir soldados inteligentes.
- Los nuevos sistemas bélicos necesitan menos dotación de personal y disponen de mucha más potencia de fuego.
- La gran complejidad militar necesita de la integración de los sistemas.
- Las operaciones se llevarán a cabo con extraordinaria velocidad y aceleración.
- Los combates se desarrollarán tanto en los campos de batalla como en los medios de comunicación.
- Las políticas y estrategias relativas a la manipulación de los medios de comunicación constituyen un elemento esencial para el logro del objetivo propuesto.
- Las nuevas operaciones deberán ser capaces de proyectar potencia y fuerzas a gran distancia y a través de operaciones conjuntas y combinadas, así como la realización de ataques simultáneos sincronizados y controlados, en tiempo real.
Para Toffler “El antiguo orden mundial, construido a través de dos siglos de industrialización, ha quedado hecho añicos. La aparición de un nuevo sistema de creación de riquezas y de una nueva forma de guerra exigen una nueva forma de paz pero, a menos que ésta refleje con precisión las realidades del siglos XXI, resultará quizás no sólo irrelevante, sino además peligrosa”.
El destacado autor italiano Carlo Jean, en su obra “Guerra, Estrategia y Seguridad”[8] nos aporta elementos interesantes, muy importantes al respecto:
- Las nuevas tecnologías militares han erosionado una de las principales funciones del Estado territorial que es la defensa de sus fronteras “naturales”, garantizando a sus ciudadanos protección y seguridad. Si éstas ya no son defendibles, la única defensa posible es el ataque estratégico. Lo cual es válido también en el campo geoeconómico.
- La cultura de cualquier pueblo, consecuencia de su experiencia histórica, de sus valores y de su religión, es esencial para cualquier formulación estratégica, ya que influye sobre su percepción y su representación geopolítica.
- Antes se combatía por el poder mediante la agresión, hoy se busca la seguridad mediante el orden.
Según éste autor, los conflictos modernos tienen las siguientes características:
- La absoluta imprevisibilidad del fenómeno guerra, su carácter mutable y su inestabilidad estructural.
- Carecen de un carácter lineal (causa-efecto).
- Existe una adecuación racional entre objetivos, costes y riesgos.
- La secuencia de la decisión comporta una interacción político-militar.
- El proceso estratégico debe ser considerado en su globalidad.
Consecuentemente la guerra, superada la Guerra Fría, se presenta como un fenómeno complejo, donde la estrategia se ha politizado y la política y la diplomacia se han militarizado. En Occidente se busca un sistema de guerra “a cero muertos”, que Luttwak ha denominado “guerra post-heroica”[9].
La guerra se compone de dos elementos básicos, la lucha de voluntades y la prueba de fuerza. La primera es de naturaleza psicológica. El objetivo ideal es conquistar sin combatir. El enfrentamiento puede ser directo o mediante la disuasión: la amenaza entendida en su conjunto como “diplomacia de la violencia”. Las voluntades pueden ser minadas indirectamente, a través de la destrucción parcial de la fuerza. La segunda es propiamente el combate. Aún así, existe una dialéctica entre ambas. Cada ataque es, a la vez, una amenaza de ataque sucesivo y, al mismo tiempo, un gesto implícito que invita a la negociación.
En los conflictos contemporáneos entender la verdadera naturaleza conceptual de los hechos y amenazas “en acto” y su proyección futura, es el primer paso hacia una verdadera resolución de los mismos. En la naturaleza estratégica coexisten factores racionales (la lógica), irracionales (la emoción, el miedo y la violencia) y arracionales (la fricción o el choque de voluntades), siendo la comprensión del ritmo del tiempo el factor esencial para cualquier conceptualización estratégica. Al respecto dice Carlo Jean: “La sorpresa puede ser conseguida sólo con una extrema compresión del tiempo… La nueva Revolución en los Asuntos Militares está basada en la reducción de los tiempos informativos y decisionales, más que en la extensión de los ataques desde el inicio sobre toda la profundidad del teatro de operaciones”.
Y retomando el tema cultural, el autor dice con claridad meridiana: “Sólo recientemente se ha reconocido la importancia de la cultura estratégica en la concepción de las doctrinas militares y sobre el modo de hacer la guerra… La cultura estratégica, en fin, influye en el modo en que son conducidas las operaciones militares… La estrategia, como la política, no se elabora en el vacío, sino que es el reflejo de la cultura de cualquier pueblo… Sólo la comprensión de la cultura estratégica puede hacer comprensible las razones de determinadas elecciones o preferencias…”
En éste sentido afirma que en los conflictos contemporáneos se ha pasado de una concepción de fuerza de último recurso, a una de fuerza en presencia, esto es, de la fuerza entendida como un instrumento orgánico de la diplomacia, tal como lo fue en el tiempo de la Pax Británica. Dice el autor: “Un éxito militar no determina la solución de un conflicto interno, más bien crea una gama de opciones, desbloqueando una situación sin salida”
Para Alain Minc[10], no hay nada que nos acerque más a la Edad Media que el analizar la estructura de los conflictos contemporáneos, caracterizados por extensas zonas sin autoridad legal. Él los denomina: “el triunfo de las sociedades grises”. En la actualidad la amenaza es el retorno a la ley de la selva. La ilegalidad se ha instalado en el seno de las democracias. Por todas partes progresa lo gris, la diferencia entre lo prohibido y lo permitido se estrecha, hasta casi desaparecer. Ante esta situación, las Instituciones y Organizaciones estáticas e incapaces de reaccionar, van perdiendo el control de la sociedad y, cada vez una menor parte de esa sociedad obedece al principio del orden. Es una situación en que todo está permitido, sin más limitaciones que la fuerza que a esos deseos presenta el oponente. ¿Como se explican esos nuevos comportamientos? Las razones son variadas y complejas:
- La liberación de los mercados y la explosión financiera.
- El individualismo egoísta.
- El hundimiento de las grandes Instituciones, a través de la feudalización de las mismas.
- La adoración del dinero y la pérdida de los contrapesos morales y religiosos.
- El sentimiento de impunidad.
- Un sentimiento de caos y disgregación social.
- El auge del narcotráfico y el terrorismo internacional.
- La corrupción generalizada de los organismos estatales.
Para el autor citado, estos riesgos en acto, mucho más peligrosos que los del medioevo por la globalización de nuestra sociedad, no deberían llegar a ocasionar un estado de caos, salvo que se produzcan en forma simultánea.
Aporta elementos interesantes, que guardan una relación estrecha con la actual realidad Latinoamericana. Expresa Minc: “El concepto de Revolución toma nuevas formas con el resurgir de nuevos Estados. Los llamados micro Estados. En una economía global, donde las transacciones económicas y monetarias se resuelven a escala mundial, ¿Tiene importancia el tamaño o la población mayor o menor de un Estado? Ciertamente la soberanía parece al alcance de cualquier tribu.”
El retorno a las Revoluciones aporta varias lecciones:
- Ningún Estado puede estar seguro indefinidamente de sus fronteras.
- No hay estructura social, por sólida o antigua que fuere, que tenga carácter permanente.
- En la actualidad, revolución no es sinónimo de subversión, sino de descomposición.
- La fuerza revolucionaria ya no pertenece a las minorías comprometidas, sino a la opinión pública, los medios de comunicación social y la justicia.
- La revolución sigue siendo una invención europea.
No puede haber previsión estratégica sin la debida reflexión, sin el manejo conceptual y esencial de la realidad sobre la que debemos actuar, pero tampoco sin el respaldo del instrumento militar necesario. Sin la “adecuada” fuerza militar y su voluntad política de empleo, la prevención será una utopía. El problema Latinoamericano es que ningún Estado-Nación posee esa fuerza adecuada a éste tiempo y circunstancia. Carecemos de voluntad política para lograr un Acuerdo de Seguridad Común, ante los hechos estratégicos en curso en la región. No hemos sido capaces de contener, “en conjunto”, el mayor y más antiguo conflicto de la región, el colombiano.
Frente a la nueva modalidad de los conflictos presentes en América del Sur, entre los cuales el narcoterrorismo es su máxima expresión, se pone de manifiesto dramáticamente la incapacidad de los Estados, actuando por separado, para poder adoptar medidas eficaces.
Como dice Minc: “Se necesita siempre lo mismo: un marco internacional, reglas homogéneas y mecanismos de vigilancia y control. Pero tales instituciones no existen. Nos acercamos al cero ideológico. Las ideas tradicionales han desaparecido y con ellas el mundo del orden. La caída del comunismo arrastró al socialismo como al liberalismo. Esta se ve afectado al haberse desarrollado como reacción al comunismo, con lo que ha perdido su estímulo, apoyo y referencia. Paradójicamente, su punto débil se sitúa en el monopolio ideológico, al ser chivo expiatorio de todos los males que afligen a la humanidad”.
Propone lo que llama “Caja de Herramientas Conceptuales”:
- Racionalizar el Mercado.
- Conocer conceptualmente las constantes que produce la Historia para poder prevenirlas.
- Las elites deben asumir y afrontar las nuevas áreas que se salen de su marco de acción.
- Adoptar políticas proactivas, pues las crisis y las situaciones inestables que desembocan en los conflictos, tienden a degenerar por naturaleza en hechos más graves.
- No buscar apoyo en principios sólidos de cohesión, que la sociedad actual no posee.
- Rescatar los principios culturales de cada sociedad, como pilar esencial de la recuperación.
- La autoridad debe cambiar su forma de actuación basada en el consenso.
- Debe tener en cuenta los efectos múltiples, actuar a la más mínima señal de riesgo.
- Debe hacerlo con flexibilidad, para poder reconducir trayectorias equivocadas.
“Lo que resulta es, pues, un arte extraño hecho de firmeza y de flexibilidad, de rigidez y movilidad, en perpetuo movimiento y, al mismo tiempo, inflexible sobre algunos puntos fundamentales. Tiene que hacer suyo un doble imperativo… imaginación y riesgo”.
Nuestros sistemas de defensa están orientados para una guerra equivocada, fuera de tiempo y espacio.
Nuestro “Sistema de Defensa”, estructurado a través de las Leyes de Defensa y de Seguridad Interior, contradice abiertamente la naturaleza del conflicto que tratamos de describir en el presente trabajo. Impide la previsión por razones ideológicas y extrapola las funciones del factor militar fuera de los límites geográficos del Estado. Y expresa lo que Gaston Bouthuol denomina “ilusionismo jurídico”[11]. Este nos crea el espejismo de concebir la esperanza de controlar el conflicto mediante la norma jurídica. No se trata de negar el papel de freno o límite que impone el Derecho Internacional en el desarrollo de la guerra, sino que resulta ilusorio pensar que, mediante normas jurídicas la sociedad pueda hacer frente y eliminar un fenómeno que el autor califica de “patológico”.
Para la sociedad latinoamericana, el estudio científico y objetivo de la guerra, no admite demoras. El poder de destrucción, la capacidad de movilización y en definitiva la posibilidad del hombre de desarrollar una guerra civil generalizada, en el seno de nuestras sociedades, exige adoptar medidas para contar con una nueva oportunidad.
Del análisis de los 366 conflictos mayores ocurridos entre 1740 y 1974, realizado por el polemólogo francés para estudiar la conflictividad en el mundo, se desprende la primacía de los motivos estructurales. Por lo tanto recomienda tratar de profundizar y buscar las razones de la guerra, más allá de las causas ocasionales, que son la manifestación visible, perceptible por nuestros sentidos. Es necesario llegar a las causas estructurales, conceptuales, donde encontraremos las verdaderas fuerzas en oposición, en forma abstracta, que conducen a engendrar la violencia colectiva.
Como expresa Barry Buzan[12]: “Hasta ahora el fin del estamento militar era ganar guerras, de ahora en adelante será evitarlas. Casi no existe otro fin útil”.
En ésta nueva tipología de las guerras, el Crimen Organizado Transanacional, adquieren un rol de actor principal.
Una definición del mismo que está usando Interpol es: “Cualquier grupo que tiene una estructura corporativa cuya el objetivo primario es obtener dinero a través de las actividades ilegales y sobrevive a menudo en el miedo y corrupción.”
El Comité Especial de las Naciones Unidas para elaborar la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se reuniría en el próximo mes de diciembre, propone la siguiente definición: “Se entiende por grupo delictivo organizado, un grupo estructurado, existente durante un período de tiempo y que tenga por fin la comisión de un delito transnacional grave, mediante la acción concertada, utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios, para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Cualquier intento por definir este fenómeno, encuentra diferencias entre los estados parte en cuanto a la dimensión subjetiva de la noción del crimen (por ejemplo, el contrabando de opio en China por comerciantes británicos durante los primeros años del siglo XIX, en violación de las leyes chinas, se definió como comercio esencial para Gran Bretaña. En el mundo de hoy, estas contradicciones todavía persisten.
Existen hechos que facilitan en desarrollo del Crimen Organizado Transnacional, como fenómeno globalizado:
La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados.
La marginación de importantes sectores en los diferentes grupos sociales.
Modificación de sistemas de comercio tradicionales.
Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este fenómeno.
Incremento de los movimientos migratorios.
Aparición de áreas de libre comercio en diversos lugares del mundo.
Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.
Falta de equidad social y económica entre países desarrollados y en desarrollo
La permeabilidad de las fronteras internacionales.
La apertura de las economías nacionales.
La velocidad de las transacciones comerciales internacionales.
La corrosión de los valores morales.
La falta de coordinación cooperativa globalizada entre los estados para combatirlo.
La falta de armonía en la legislación específica nacional e internacional para combatir este fenómeno.
La falta de organismos supranacionales para la aplicación de las leyes.
Los fines que en general, se le atribuyen a las diferentes organizaciones criminales transnacionales son:
Obtener, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de dinero, a través de las actividades lícitas e ilícitas.
Corromper las estructuras gubernamentales.
Destruir los sistemas económicos nacionales.
Constituir factores de poder
Establecer alianzas
Ejercer el poder utilizando cualquier medio.
CONCLUSIÓN
Bajo circunstancias normales, la represión del narcoterrorismo es una tarea que corresponde única y exclusivamente a las autoridades civiles responsables de imponer la ley, pero, ¿deberíamos aceptar las circunstancias actuales como normales? El profundo daño causado por el narcotráfico en Colombia y en México, es evidencia de la naturaleza devastadora de esta amenaza. Ya es hora de reconocer la magnitud de los problemas creados por el Crimen Organizado Transnacional en nuestro territorio y ya es hora de controlar esta situación.
Ante el alto grado de vulnerabilidad y de disfuncionalidad en que se encuentran los sistemas de Defensa de los países miembros del MERCOSUR, considerando las particularidades descriptas, es indispensable encontrar un camino hacia un sistema de Seguridad Estratégica Regional, que preserve un futuro político en Paz, frente a los actuales, nuevos y poderosos riesgos y amenazas internacionales en presencia. Salvaguardar al Estado, como instrumento de Seguridad, Justicia y Equidad Social, es el desafío estratégico primordial en la posguerra fría.
La sinergia que se produce entre terror y crimen, contribuye sin duda a debilitar las alianzas internacionales, a licuar el poder político de los Estados y a minar progresivamente la efectividad de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, en particular en aquellos países cuyas dirigencias están comprometidas con el nuevo fenómeno o se encuentran estratificadas en su conceptualización estratégica.
El Sub-Continente queda así fuertemente relacionado con los complejos y ocultos actores del eventual Califato Euro-Asiático, desarrollando a Ibero América como “espacio sin ley”, organizado con entidades sociales horizontales, autogestionadas, desde la anarquía anti-institucional en plena experiencia en los suburbios de Caracas, en los últimos años. Los despliegues de las veinte bases militares “bolivarianas” en las fronteras bolivianas con Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, así parecen confirmarlo.
Las acciones conjuntas, que tienen como eje en Colombia al narcoterrorismo encabezado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con los carteles de la droga ligados también a otras formaciones políticas, como la anticomunista Fuerzas de Autodefensa de Colombia y a sociedades criminales como la mafia rusa, deben encontrar una respuesta definitiva que no puede terminar sino en la derrota, rendición incondicional y erradicación definitiva de esos flagelos mundiales en nuestra región.
En el caso de la Argentina, al desafío global y regional la encuentra en un estado generalizado de inseguridad nacional, sin previsiones, sin estructuras orgánicas actualizadas y sin voluntad de defensa. La sociedad anómica, también está anestesiada. Subsiste bajo una conducción inconscientemente irresponsable.
Esta exigencia conduce indefectiblemente al MERCOSUR POLÍTICO y éste tendrá entidad cuando se logre una Política de Defensa Común, a través de un Acuerdo de Seguridad Colectivo. La naturaleza de los principales hechos y amenazas estratégicas del continente, el narcotráfico y el terrorismo, operando sobre sociedades empobrecidas y Estados Nacionales débiles, con sus instituciones malversadas y sus sistemas políticos no consolidados, no ha encontrado una respuesta combinada y unificada, que tenga en cuenta las características internacionalizadas y flexibles de una agresión estratégica diluida, no militar. Allí encontramos el verdadero desafío que debemos afrontar.
BILIOGRAFIA
Beaufré, André. “Introducción a la Estrategia”, Editorial Struhart & Cia, Buenos Aires, 1982.
Corrado, Jorge. “Defensa, Guerra y Seguridad Estratégica en el siglo XXI”, Anales Universidad Católica de La Plata, Facultad de Ciencias Sociales, año 2006.
Corrado, Jorge. “Una Segunda Argentina es Posible”. Anales de la Universidad Católica de La Plata, Facultad de Ciencias Sociales, año 2007.
Cosidó, Ignacio y otros. “El final de la disuasión”, Grupo de Estudios de Estrategia de España, Política Exterior. Noviembre-Diciembre de 2001. www.gees.org
Dobriansky, Paula. “El crecimiento explosivo del Crimen Organizado Transnacional”, Subsecretaria de EEUU para Asuntos Mundiales. Departamento de Estado de EEUU, 20 de Agosto de 2001.
Auel, Heriberto y otros. “Geopolítica Tridimensional Argentina”, Editorial Eudeba, Bs. As. 1999
Bardají, Rafael. “Del viejo al nuevo orden estratégico. A diez años de la caída del Muro”. Revista Española de Defensa, nº 141, noviembre de 1999, pag. 30.
Lobaiza, Humberto. “La Argentina Indefensa”. Círculo Militar, Buenos Aires, 1997.
Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. “Las Guerras de la Tercera Especie”. www.ieeba.com.ar – Buenos Aires 2001.
Hamon, Leo. “Estrategia contra la Guerra”, Ediciones Guadamarra, Madrid, 1966.
Holsti, Kalevi. “The State, War and the State of War”. Cambridge University Press. 1999.
Lind, Samuel, Schmitt, John y Wilson, Gary. “The Changing Face of War. Into the Fourth Generation”. Marine Corps Gazette, Octubre 1989.
Van Cleveld, Martín. “The Transformation of War”. The Free Press, Nueva York, 1991.
Wright, Robin y MacManus, Doyle. “Futuro Imperfecto”. Ediciones Giralbo, Barcelona, 1992.
Toffler, Alvin y Heidi. “Las Guerras del Futuro”. Ediciones Plaza & Janes, 1994.
Jean, Carlo. “Guerra, Estrategia y Seguridad”. Editorial Laterza, Roma, 1997.
Luttwak, Edward. “Estrategia, la lógica de la guerra y la paz”. Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1992.
Minc, Alain. “La Nueva Edad Media. El gran vacío ideológico”. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1994.
Luttwak, Edward. “Estrategia e Historia”. Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1985.
Bouthuol, Gaston. “Las Guerras. Elementos de Polemología”. Editorial Payot, París, 1951.
Buzan, Barry. “Introducción a los Estudios Estratégicos: tecnología militar y relaciones internacionales”. Ediciones Ejército, Madrid, 1987.
Ministerio de Defensa de Colombia. Sistema de Información de la Defensa Nacional. Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá, enero de 2001
Pagina de Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires: www.ieeba.com.ar
El Dr. Jorge Corrado es Abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado estudios de posgrado en Inteligencia Estratégica, Geopolítica y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Es Vicepresidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires y Profesor Titular y Coordinador General Académico en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
[1] Corrado Jorge. “Las Guerras de la Tercera Especie”. Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Buenos Aires 2001.
[2] Hamon, Leo. “Estrategia contra la Guerra”, Ediciones Guadamarra, Madrid, 1966.
[3] Holsti, Kalevi. “The State, War and the State of War”. Cambridge University Press. 1999.
[4] Lind, Samuel, Schmitt, John y Wilson, Gary. “The Changing Face of War. Into the Fourth Generation”. Marine Corps Gazette, Octubre 1989.
[5] Van Cleveld, Martín. “The Transformation of War”. The Free Press, Nueva York, 1991.
[6] Wright, Robin y MacManus, Doyle. “Futuro Imperfecto”. Ediciones Giralbo, Barcelona, 1992.
[7] Toffler, Alvin y Heidi. “Las Guerras del Futuro”.Ediciones Plaza & Janes, 1994.
[8] Jean, Carlo. “Guerra, Estrategia y Seguridad”.Editorial Laterza, Roma, 1997.
[9] Luttwak, Edward. “Estrategia, la lógica de la guerra y la paz”.Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1992.
[10] Minc, Alain. “La Nueva Edad Media. El gran vacío ideológico”. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1994.
[11] Bouthuol, Gaston. “Las Guerras. Elementos de Polemología”.Editorial Payot, París, 1951.
[12] Buzan, Barry. “Introducción a los Estudios Estratégicos: tecnología militar y relaciones internacionales”. Ediciones Ejército, Madrid, 1987.
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()